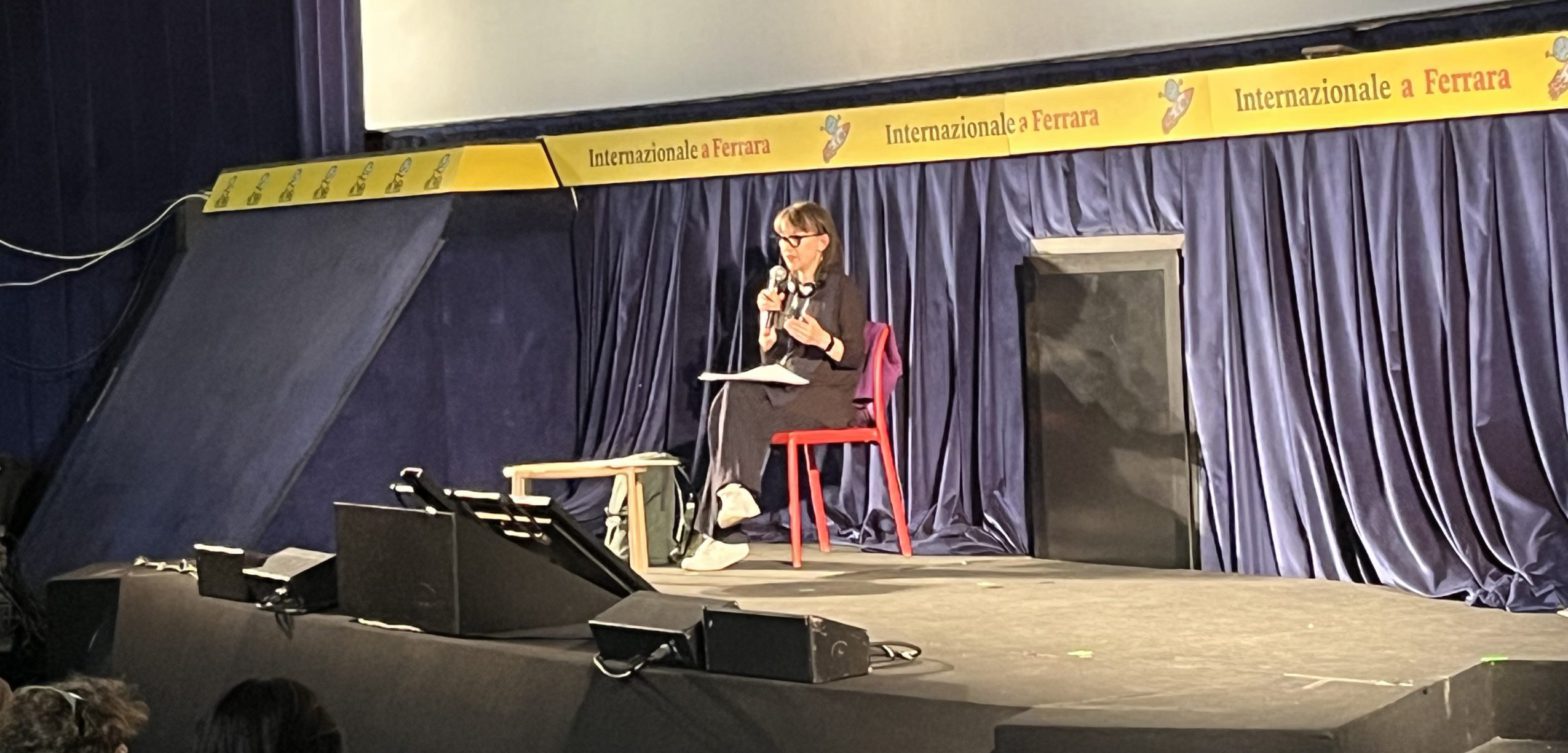“Non è possibile parlare della Cina, senza parlare della Rivoluzione culturale”.
Così può essere riassunto l’incontro del Festival Internazionale di Ferrara, tenuto da Tania Branigan, il 4 ottobre 2025 al cinema Apollo.
La giornalista britannica ha parlato della sua ultima pubblicazione: Memoria rossa. La Cina dopo la Rivoluzione culturale (Iperborea, 2025), nella quale viene esplorato il periodo della rivoluzione culturale cinese (1966-1976) attraverso i punti di vista di persone che l’hanno vissuta sulla propria pelle: la testimonianza di un uomo che da bambino denunciò la madre per aver criticato Mao Zedong, i racconti amari di donne e uomini strappati dalle proprie case, deportati e costretti a lavorare nelle campagne, il dolore di un compositore torturato dalle guardie rosse (gruppi di studenti che commettevano violenze e soprusi, seguaci di Zedong). Le storie raccolte in questo libro servono a ricordare un passato che lo Stato cinese vorrebbe dimenticare, un passato composto da dieci anni di violenza, di caos, in cui milioni di persone sono state uccise e decine di milioni perseguitate. La rivoluzione è iniziata dopo il fallimento del “grande balzo in avanti”, ideato e pianificato da Zedong, che portò alla morte per carestia di innumerevoli cinesi, e dopo il vano tentativo da parte del governo di allontanare lo stesso Zedong dalle posizioni di potere; a lui rimasero però tutti i massimi ruoli ideologici, tra cui la carica di presidente del Partito Comunista Cinese. Nei primi tempi le guardie rosse si limitavano a commettere piccoli crimini, che rispecchiavano gli ideali del partito, come bruciare e rovinare ai passanti vestiti di seta o troppo “alla moda” e distruggere acquari e aiuole fiorite, considerate borghesi, e quindi sbagliate. La situazione è degenerata violentemente: purghe, sequestri, torture e omicidi divennero prassi, anche solo parlare male all’interno della propria casa di Zedong o del Partito rischiava di portare a una condanna a morte. “Era come se il mondo si fosse ribaltato”: denunciarsi a vicenda, anche tra parenti o amici, in una sorta di frenetica caccia alle streghe, era diventato comune. Le idee “confuciane”, che per secoli avevano modellato la cultura cinese, come il rispetto dei giovani per gli anziani, erano state dimenticate in favore di una follia paranoica, durante la quale le persone si denunciavano a vicenda per paura di essere tradite a loro volta.
“Ai bambini era stato insegnato che mamma e papà sono cari, ma il presidente Zedong è più caro”.
Attualmente, però, l’opinione pubblica cinese sembra essere ambivalente: se da una parte molti tra quelli che hanno vissuto il periodo della rivoluzione in prima persona lo ricordano con orrore e angoscia, dall’altra c’è chi ne parla con nostalgia e lo considera un tempo di valori reali e concreti, nella quale le autorità si curavano del popolo con vero interesse.
Nonostante i tentativi del governo di cancellare questa parte della storia, il ricordo degli orrori e degli abusi rimane indelebile e segna ancora la Cina odierna.