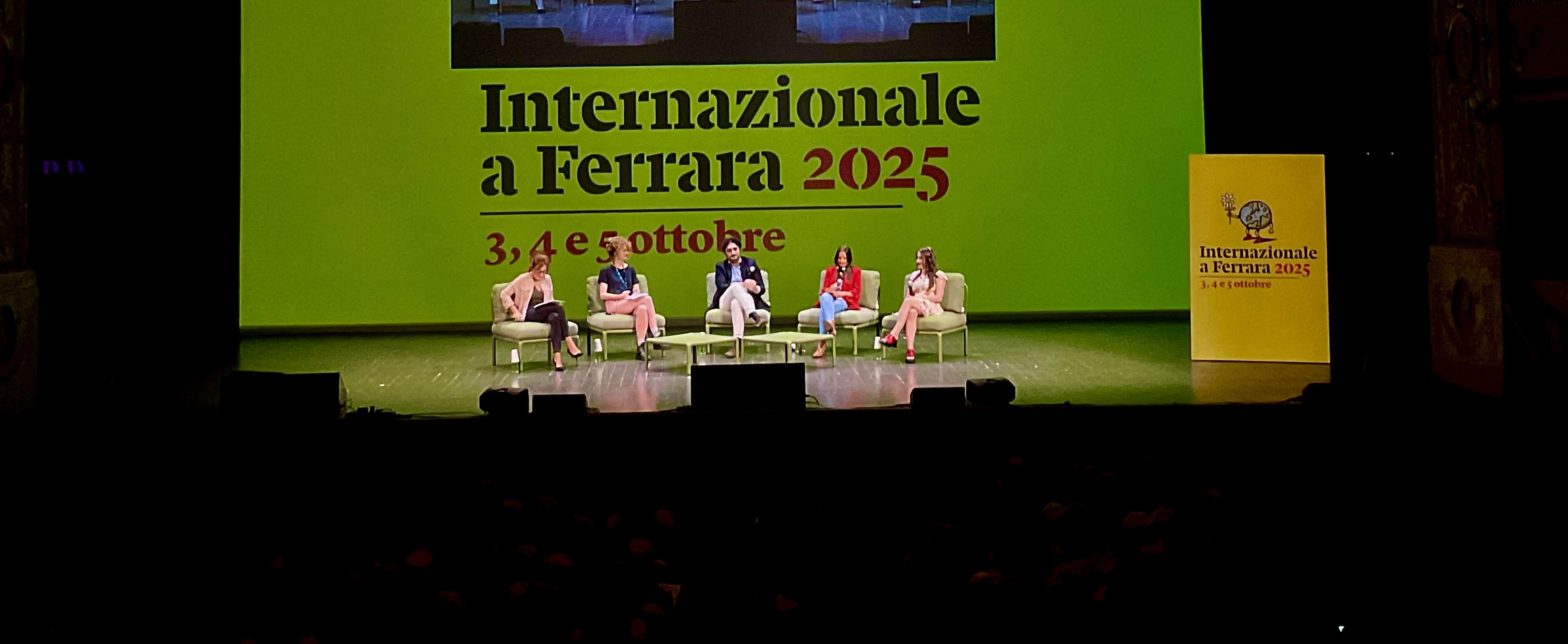Disinformazione: disseminazione di informazioni che siano false e verificabili come tali o fuorvianti, diffuse allo scopo di lucro o inganno, oppure che abbiano la capacità di creare un danno pubblico o alla sicurezza; questa la definizione che Raffaele Di Giovanni Bezzi, rappresentante della Commissione Europea, fornisce basandosi sul Codice di condotta della disinformazione firmato nel 2018.
A dialogare di questo tema con lui nel suggestivo ambiente del Teatro Comunale in occasione di Internazionale a Ferrara sabato 4 ottobre, Katz Laszlo, speaker del podcast The Europeans, Raquel Miguel Serrano, di EU disinfoLab, e Marianna Spring, giornalista investigativa della BBC moderati da Sara Zambotti di Rai Radio2.
Quando si parla di disinformazione, spesso non ci si chiede il motivo per cui essa continui ad essere prodotta incessantemente e secondo gli ospiti i motivi sono diversi: a volte può succedere che alla base di questo fenomeno ci sia un’insufficienza di fondi che impedisce ai giornalisti di contattare fonti abbastanza autorevoli, altre volte invece nasce per il processo confusionario dello scrivere sempre nuove storie in cui si contesta implicitamente l’altro al posto di correggere direttamente un errore. Tuttavia i due principali motivi, che spesso vengono sottovalutati, sono di natura politica: non è mai una singola persona a diffondere fake news ma alle spalle ci sono campagne politiche molto sofisticate appositamente realizzate per mettere in cattiva luce le istituzioni, ne è un esempio il caso Doppelgänger nel quale un’organizzazione russa aveva clonato i siti ufficiali di diverse testate giornalistiche internazionali per diffondere più velocemente notizie false, il secondo motivo principale è lo scopo di lucro poiché molti ricavano guadagno dalla disinformazione.
Anche se a livello europeo non esiste effettivamente una legge che sanzioni chi diffonde informazioni non veritiere esistono delle linee guida che permettono alle grandi aziende di autoregolamentarsi al fine demonetizzare la misinformazione, altro strumento fondamentale è il Digital Services Act, che obbliga al monitoraggio dei rischi sistemici facendo dunque una selezione accurata tra i contenuti scegliendo informazioni in base alla qualità e non alla quantità.
A impegnarsi attivamente contro la disinformazione sono anche i giornalisti stessi. Laszlo crede che sia importante identificare coloro che diffondono false notizie, entrare nel meccanismo che porta le loro menti a credere e diffondere teorie complottiste e dialogare con essi, in modo da presentare loro diversi approcci, per responsabilizzarli e renderli in grado di svolgere un lavoro corretto ed efficiente.
I primi a dover contrastare la disinformazione però siamo noi che, sfruttando il buon senso e rimando informati, dobbiamo sempre porci domande su ciò che vediamo e mai affidarci ciecamente a ciò che sentiamo. Come dice Marianna Spring “le persone tendono a dare credito solamente a chi condivide le loro stesse opinioni perché tante volte non si vuole considerare l’idea di avere torto”. Tuttavia se l’essere umano imparasse a mettersi in dubbio, riconoscendo i suoi limiti e non diffondendo conoscenze al di fuori del suo ambito di competenza, ognuno di noi potrebbe dare il proprio contributo alla circolazione di notizie sicure e veritiere.